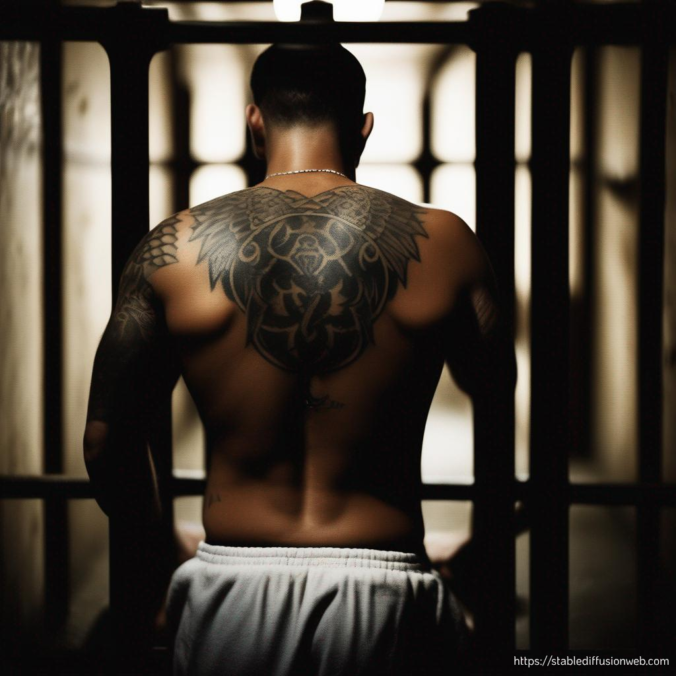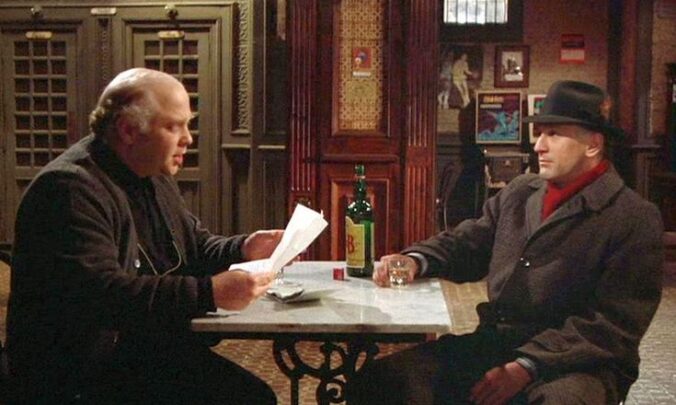Parte uno
ANDREA
Il carcere è un tema che ha da sempre esercitato un forte fascino sulla musica contemporanea. Dagli albori del rock’n roll fino ad oggi, infatti, numerosi artisti si sono misurati con questo argomento.
Con questo articolo vogliamo iniziare un ciclo di articoli a tema musicale, per mostrare a modo nostro l’intreccio tra il carcere e la musica nelle sue varie forme.
Iniziamo dalle prime rappresentazioni musicali del mondo-carcere: siamo negli anni ‘50 del secolo scorso, negli Stati Uniti d’America. Personaggi iconici come Elvis Presley e Johnny Cash furono tra i primi ad affrontare il tema del carcere, in maniera molto diversa tra loro, puntando i riflettori sul carcere e sulla vita che si svolge al suo interno.
Elvis Presley propose un’immagine edulcorata, ridente, del carcere e della detenzione nella celeberrima Jailhouse Rock, dove non c’è spazio per il dolore e la sofferenza, ma dove la musica rock’n roll del cantante di Memphis racconta l’irrefrenabile voglia di ballare che dilaga in tutta la prigione, in un ballo che coinvolge agenti e detenuti in una sorta di festa all’interno del carcere. Nulla di più fantasioso! Elvis rappresenta infatti con uno stile spensierato e disimpegnato la cultura giovanile degli anni ‘50, mostrando il tempo trascorso in carcere come una festa senza fine, dove non c’è spazio per la sofferenza e per questioni sociali, ma solo per il divertimento.
Di tutt’altra impronta invece è la rappresentazione data da Johnny Cash, coevo di Elvis, al tema carcere. Molto più realistica la sua narrazione, quasi una narrazione “da dentro” (anche se l’esperienza carceraria di Johnny Cash avvenne quando era già famoso), che trasuda empatia e vicinanza alle precarie condizioni di vita dei detenuti. Una vicinanza che l’artista ha voluto dimostrare con un evento storico: il celeberrimo concerto nella prigione di Folsom. Il 13 gennaio del 1968 infatti Johnny Cash si esibì, insieme alla sua band, per il primo concerto gratuito svolto all’interno di un carcere, davanti ai 2000 ospiti del penitenziario di massima sicurezza di Folsom in California. A dare ancora maggior spessore culturale all’evento fu il fatto che la canzone di chiusura, Greystone Chapel, fu scritta da una persona detenuta proprio a Folsom, e fu interpretata per la prima volta da Johnny Cash nello storico concerto del 1968. Il tutto è poi confluito in un disco, “At Folsom prison”, un disco storico, del quale consigliamo vivamente l’ascolto.
Arrivare a suonare in una prigione fu naturale per Johnny Cash, che spesso aveva trattato il tema della detenzione nelle sue canzoni. Alla prigione di Folsom un giovane Johnny Cash, nel 1955, dedicò una canzone, dopo aver visto un film-documentario che trattava il tema della vita nell’istituto californiano. La canzone si intitolava “Folsom Prison Blues”, usata 13 anni dopo dall’artista come apertura per il live “At Folsom prison”.
Molte canzoni cantate da Johnny Cash trattarono il tema del carcere, almeno una ventina, ma forse quella che più ci ha colpito è “San Quentin”. La canzone parla del penitenziario di San Quentin, teatro di un altro concerto dell’artista, uscito sulla scia del live a Folsom (At San Quentin, 1969), penitenziario che in tempi più recenti ha prestato la sua location per il video di “St. Anger” dei Metallica, registrato nel carcere di San Quentin nel 2003 dalla band metal americana, in un video che mostra l’interno del carcere e centinaia di detenuti spettatori dell’evento inconsueto. In “San Quentin” Johnny Cash racconta il carcere in maniera critica, attacca in maniera diretta e decisa il sistema-carcere che, a detta dell’artista, non rieduca ma tende solo alla distruzione delle persone che lo vivono. La canzone esprime una forte rabbia e un’idea di ribellione, che ben viene espressa dalla risposta che danno i detenuti che la ascoltano per la prima volta, il 23 febbraio del 1969 a San Quentin.
Anche grazie a questa canzone e all’eco della sua esibizione a San Quentin, Johnny Cash consolidò la sua immagine di “cantore degli emarginati”, confermandosi come un cantante carismatico e dalla forte sensibilità sociale. Tra i detenuti americani, ovviamente, la sua figura divenne leggendaria. Per la prima volta un artista di fama internazionale, che ad oggi ha venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo, mostrava attenzione verso la reale condizione dei detenuti, senza rifugiarsi in ricostruzioni fantasiose ed edulcorate. L’empatia profonda di Cash si può notare in altre canzoni sul tema, canzoni che parlano di carcere, di condannati a morte, di come si vive sia nei reparti per detenuti comuni che nel braccio della morte. Per esempio “Jacob Green” parla del suicidio di un giovane detenuto, che non sopporta più le condizioni di vita del carcere; “Austin Prison” racconta del tentativo di fuga, finito tragicamente con l’uccisione del fuggitivo, di un detenuto nel carcere di Austin. Un’altra canzone che merita di essere citata è “25 minutes to go”, canzone interpretata da Cash ma scritta dal poeta e musicista Shel Silverstein. La canzone racconta gli ultimi 25 minuti di vita di un condannato a morte per impiccagione, in una sorta di macabro conto alla rovescia in cui in maniera sarcastica ogni strofa cantata esprime lo scadere di un minuto, fino ad arrivare al momento in cui il cappio si stringe intorno al collo e la canzone si interrompe bruscamente.
Sulla figura di Johhny Cash si potrebbe scrivere tantissimo, avendo avuto una lunghissima carriera, che ha attraversato ben 6 decadi, ed è stato spunto per musicisti, registi e artisti in genere. La sua influenza sulla musica occidentale infatti è indubbia, come la profondità e la sensibilità con cui ha affrontato alcune tematiche sociali.
Speriamo che gli spunti offerti in queste poche righe siano utili per chi ci legge, e soprattutto che vi sia venuta voglia di ascoltare quanto proposto in questa prima digressione sul tema “musica e carcere”, che continuerà presto su queste pagine.
Buon ascolto!