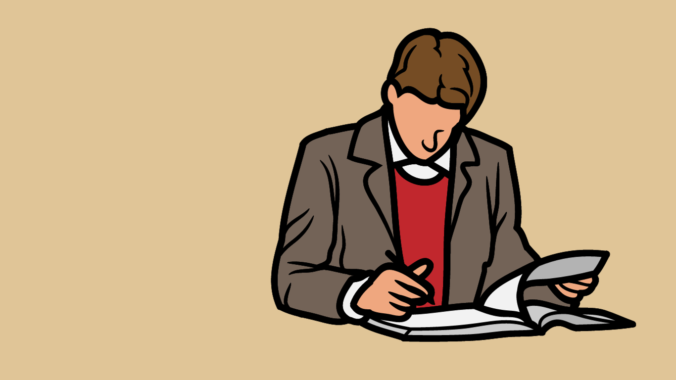ANDREA
Nel settembre dello scorso anno la notizia di disordini e di una rivolta scoppiata tra i detenuti del carcere di Regina Coeli a Roma ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica l’annoso problema delle condizioni di vita delle persone detenute e delle problematiche connesse alla vita detentiva. Una protesta di questa portata non si registrava da anni, addirittura un’intera sezione dell’istituto romano è stata colpita dalla sommossa, che ha provocato incendi e ha reso l’intero reparto inagibile, con il conseguente trasferimento dei detenuti che vi erano ristretti. Il dibattito pubblico sul tema, purtroppo, è condizionato dalle valutazioni populistiche dei politici, da affermazioni date in pasto ai media che tendono ad alimentare il pregiudizio verso il carcere e verso le persone che, loro malgrado, lo abitano o lo hanno abitato.
Per questo motivo è complesso affrontare questa tematica, che necessiterebbe di ben altro spazio e di un’analisi più approfondita. Oggi vogliamo concentrarci sulle rivolte carcerarie avvenute in Italia, soprattutto su quelle degli anni 60/70 del secolo scorso, e sulla pressione esercitata allora sull’opinione pubblica e sulla politica, che ha portato alla stesura dell’ordinamento penitenziario del 1975.
Il tema della rivolta carceraria da sempre ha colpito la fantasia dell’opinione pubblica, incentivata da rappresentazioni non sempre realistiche veicolate dai media e dalla produzione artistica in vari campi (cinema, musica, teatro…).
Il contesto degli anni Sessanta che conduce alle rivolte delle carceri
Negli anni ‘60, grazie al diffondersi di ideali politici di rottura e alla centralità data ai diritti umani dai movimenti politici attivi in varie parti del mondo, una nuova coscienza sociale ha portato ad una crescente insoddisfazione nei confronti delle istituzioni penitenziarie. La funzione repressiva e punitiva, fino ad allora imperante, portava il carcere ad essere una sorta di discarica sociale, in cui venivano relegati gli elementi più scomodi, marginali, in un’ottica di repressione di classe. Numerosi studiosi iniziano ad affrontare il tema della repressione e delle istituzioni totali, tra i più popolari a livello mondiale inseriamo sicuramente Erving Goffman, il quale si concentrò maggiormente sull’istituzione del manicomio e sulla gestione della salute mentale, ma i parallelismi tra manicomio e carcere sono palesi ed ovvi, se letti entrambi utilizzando concetti come quello di “istituzione totale”, coniato da Goffman ed entrato ormai nel vocabolario comune. Tra gli altri studiosi che hanno contribuito, con le loro opere, ad un approccio critico nell’affrontare il tema del carcere e delle istituzioni totali più in generale ricordiamo Michel Foucault (“Sorvegliare e punire. Nascita della prigione” uscito nel 1975) e, in Italia, lo psichiatra Franco Basaglia, molto attivo nella battaglia per l’umanizzazione dell trattamento psichiatrico, che ha portato alla fondamentale e innovativa legge che ancora oggi porta il suo nome. Il dibattito che è seguito alle analisi degli studiosi è riuscito quindi ad influenzare la politica, rendendo il tema della riforma del sistema carcere una priorità in Italia.
Riguardo alla situazione carceraria in Italia è da menzionare un’opera pioneristica, consigliandola a chi non l’avesse ancora letta, ovvero il seminale testo uscito nel 1971: “Il carcere in Italia” di Rizzi e Salierno, una fotografia impietosa del carcere pre-riforma dell’ordinamento penitenziario.
Salierno offrì una panoramica approfondita del carcere pre-riforma, utilizzando la propria esperienza personale di detenuto, e applicando una lente critica che lo portò a mostrare le contraddizioni in cui versava il sistema penitenziario precedente al 1975, specchio di forti disuguaglianze sociali. Il lavoro di Salierno portò quindi a considerare il carcere non soltanto come un luogo di detenzione, ma come un contesto in cui emergevano con chiarezza le complesse dinamiche di potere, esclusione e marginalizzazione dei reietti della società.
Le rivolte, adottando quest’approccio, non vengono viste semplicemente come atti di ribellione, ma come manifestazioni di idee importanti, espressioni di una richiesta profonda di dignità e giustizia sociale proveniente da individui di fatto abbandonati dalla società, relegati in una istituzione che fino a quel momento ha avuto la funzione di raccoglitore del disagio, con lo scopo di mettere da parte e togliere dalla visibilità pubblica gli elementi considerati pericolosi, che avrebbero rischiato di minare alla base la sicurezza della società borghese del secondo novecento. Salierno nel suo imponente lavoro affrontò e denunciò la violenza istituzionale e gli abusi di potere, purtroppo all’ordine del giorno, l’isolamento e la spersonalizzazione delle persone recluse e la mancanza di programmi rieducativi. L’importanza del lavoro di Salierno e delle riflessioni che ne sono scaturite ha condizionato il clima politico del tempo. Tra gli addetti ai lavori il suo testo ha avuto molto successo, essendo la prima ricerca sul campo, facilitata dall’esperienza detentiva vissuta dall’autore. Le politiche pubbliche che investivano il mondo carcerario quindi, nell’idea di Giulio Salierno, andavano riformate radicalmente, le pratiche all’interno delle carceri andavano ripensate, bisognava rielaborare il concetto di riabilitazione, sostituendolo a quello, ormai obsoleto ed ingiusto, di mera punizione.
Le rivolte e i detenuti politici
Già dal 1945 in Italia si affacciarono fatti di cronaca che avevano come protagonisti i detenuti e le loro rivolte, ma per una presa di coscienza vera e propria, e per parlare di movimento dei detenuti, dobbiamo aspettare le lotte dei detenuti avvenute nel biennio 1968/1969. In quegli anni la composizione della popolazione detenuta stava cambiando radicalmente: molti giovani provenienti dai movimenti politici antagonisti entravano in carcere, come conseguenza della repressione esercitata su chi partecipava ad attività politiche, anche violente, ormai diffuse su tutto il territorio italiano e non solo. Per la prima volta entravano in massa nuovi detenuti, con un background politico definito e una formazione scolastica più avanzata di chi fino a quel momento aveva riempito le carceri italiane. Si diffuse quindi a macchia d’olio il dissenso tra le persone detenute di tutta la penisola, questa volta in una forma di movimento sociale più strutturato che, a differenza delle ribellioni avvenute dal secondo dopoguerra in poi, che avevano come obiettivo la risoluzione di singole questioni pratiche e rivendicazioni inerenti la vita quotidiana, aveva come obiettivo dichiarato una riforma profonda del sistema penitenziario, una riforma radicale che doveva modificare quel luogo che fino ad allora era destinato alla punizione e a null’altro.
Le rivolte carcerarie esprimevano una manifestazione di malessere profondo e radicato, tendevano a far emergere le contraddizioni insite nel sistema penitenziario, evidenziando le ingiustizie e la natura profondamente classista della giustizia italiana. Il deflagrare delle rivolte carcerarie ha quindi portato l’opinione pubblica a focalizzarsi sul carcere, a cominciare a riflettere sul futuro delle persone che vi sono ristrette. La pressione dell’opinione pubblica ha portato all’azione il sistema politico, con la stesura di un ordinamento ancora oggi considerato all’avanguardia per le soluzioni proposte in ottica rieducativa e di reinserimento sociale.
Carceri: dalle rivolte alla riforma
Il culmine di questo processo appare quindi nel 1975 con la riforma dell’ordinamento penitenziario italiano, ancora in vigore, che ha introdotto concetti molto all’avanguardia per il tempo come quello di reinserimento sociale, di trattamento, di osservazione scientifica della personalità, di misure alternative alla detenzione. La multidisciplinarietà è la chiave per comprendere al meglio la personalità della persona detenuta, per elaborare un percorso di reinserimento sociale valido, finalizzato al reale reinserimento. La sfida dell’ordinamento penitenziario e della ventata politica del tempo fu riposta nell’idea di trasformare le carceri da luoghi di punizione a spazi dedicati alla riabilitazione e al reinserimento. I programmi educativi e formativi, nell’idea che ha ispirato il legislatore, possono ridurre il tasso di recidiva, e contribuire quindi a modellare una società più giusta.
Sicuramente i movimenti politici, sia interni che esterni al mondo carcerario, hanno influenzato le scelte politiche che hanno portato alla riforma del 1975.
La domanda che ci poniamo oggi è la seguente: è possibile che le rivolte carcerarie recenti siano nuovamente un campanello d’allarme che non possa essere trascurato, che meriterebbe come risposta una presa di coscienza del problema-carcere da parte della politica, la quale dovrebbe aprire una riflessione seria che coinvolga gli addetti ai lavori e le persone detenute per portare ad una nuova svolta, ad un ulteriore passo in avanti verso un’istituzione carceraria diversa da quella che conosciamo, più in linea con quello che è il suo mandato costituzionale?
La speranza, vista la criticità del sistema penitenziario che vediamo oggi, è che si colgano gli input provenienti anche dall’Unione Europea, finalizzati a rendere più umano e non degradante il percorso carcerario in Italia, che ciò porti ad una consapevolezza diffusa che le migliaia di corpi ammassati nelle carceri italiane in condizioni spesso difficili, in realtà sono abitati da persone, individualità portatrici di diritti al pari di chi non è nella condizione di detenuto, e ancor di più: le persone detenute possono essere delle risorse per la collettività, possono e devono diventarlo. Il compito della politica a questo punto sarebbe il favorire la costruzione di un sistema diverso, in cui ci siano effettivamente pari opportunità per tutte e tutti, realizzando quanto previsto dalla Costituzione del 1948.
Per concludere il tema affrontato ci concediamo una digressione nel mondo della musica italiana, riportando un testo che esprime molto i concetti finora espressi, frutto di una delle menti più sensibili ed acute mai esistite nel panorama musicale italiano: Fabrizio De Andrè.
La sua “Nella mia ora di libertà”, uscita nel 1973, ci catapulta direttamente nel contesto di quegli anni, raccontando la storia di un detenuto e della sua presa di coscienza politica avvenuta in carcere, esperienza che culmina con una rivolta carceraria. Ci sono tutti i temi che abbiamo affrontato in questa parziale disamina, arricchiti dalla potenza evocativa della poetica di Fabrizio De André, in una testimonianza splendida che non può lasciare indifferenti.
Fabrizio De André – Nella mia ora di libertà
Di respirare la stessa aria
D’un secondino non mi va
Perciò ho deciso di rinunciare
Alla mia ora di libertà
Se c’è qualcosa da spartire
Tra un prigioniero e il suo piantone
Che non sia l’aria di quel cortile
Voglio soltanto che sia prigione
Che non sia l’aria di quel cortile
Voglio soltanto che sia prigione
È cominciata un’ora prima
E un’ora dopo era già finita
Ho visto gente venire sola
E poi insieme verso l’uscita
Non mi aspettavo un vostro errore
Uomini e donne di tribunale
Se fossi stato al vostro posto
Ma al vostro posto non ci so stare
Se fossi stato al vostro posto
Ma al vostro posto non ci so stare
Fuori dell’aula sulla strada
Ma in mezzo al fuori anche fuori di là
Ho chiesto al meglio della mia faccia
Una polemica di dignità
Tante le grinte, le ghigne, i musi
Vagli a spiegare che è primavera
E poi lo sanno, ma preferiscono
Vederla togliere a chi va in galera
E poi lo sanno, ma preferiscono
Vederla togliere a chi va in galera
Tante le grinte, le ghigne, i musi
Poche le facce, tra loro lei
Si sta chiedendo tutto in un giorno
Si suggerisce, ci giurerei
Quel che dirà di me alla gente
Quel che dirà ve lo dico io
Da un po’ di tempo era un po’ cambiato
Ma non nel dirmi amore mio
Da un po’ di tempo era un po’ cambiato
Ma non nel dirmi amore mio
Certo bisogna farne di strada
Da una ginnastica d’obbedienza
Fino ad un gesto molto più umano
Che ti dia il senso della violenza
Però bisogna farne altrettanta
Per diventare così coglioni
Da non riuscire più a capire
Che non ci sono poteri buoni
Da non riuscire più a capire
Che non ci sono poteri buoni
E adesso imparo un sacco di cose
In mezzo agli altri vestiti uguali
Tranne qual è il crimine giusto
Per non passare da criminali
Ci hanno insegnato la meraviglia
Verso la gente che ruba il pane
Ora sappiamo che è un delitto
Il non rubare quando si ha fame
Ora sappiamo che è un delitto
Il non rubare quando si ha fame
Di respirare la stessa aria
Dei secondini non ci va
E abbiam deciso di imprigionarli
Durante l’ora di libertà
Venite adesso alla prigione
State a sentire sulla porta
La nostra ultima canzone
Che vi ripete un’altra volta
Per quanto voi vi crediate assolti
Siete per sempre coinvolti
Per quanto voi vi crediate assolti
Siete per sempre coinvolti